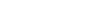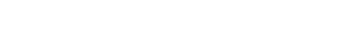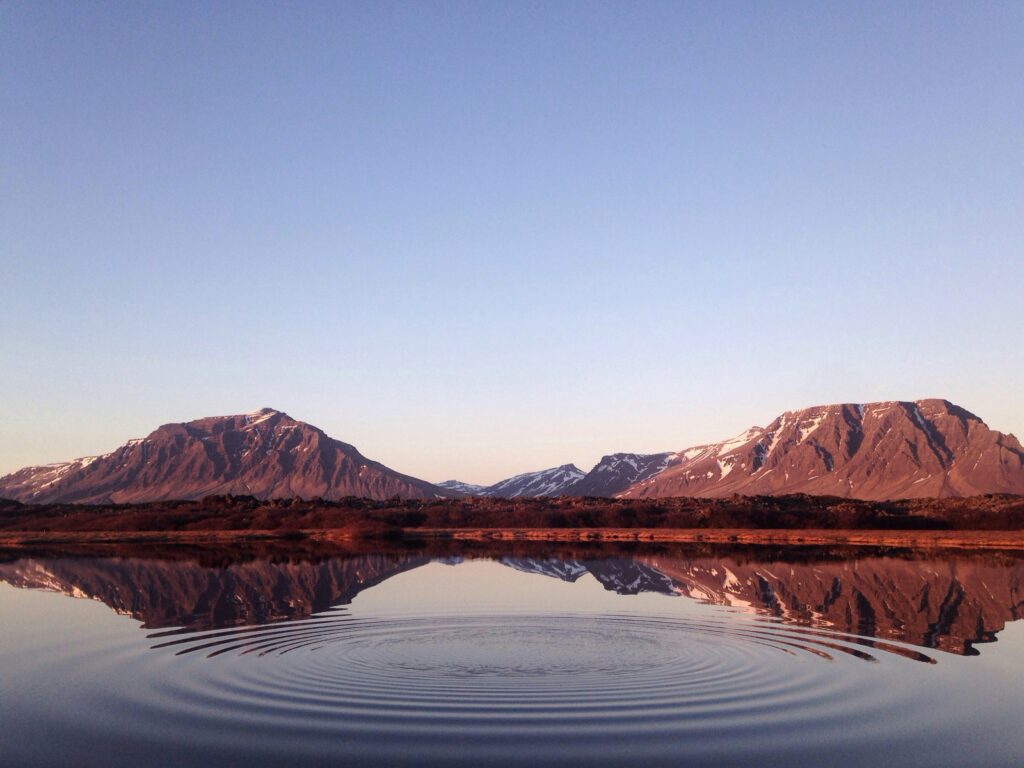Claudia è nata a Rolo (Reggio Emilia) nel 1970, d’estate, la sua stagione preferita. Si è appassionata alla musica e alla fotografia fin da piccola. Il primo libro che lesse, a 10 anni, era della Fallaci e Claudia voleva una vita avventurosa come la sua.
Claudia è nata a Rolo (Reggio Emilia) nel 1970, d’estate, la sua stagione preferita. Si è appassionata alla musica e alla fotografia fin da piccola. Il primo libro che lesse, a 10 anni, era della Fallaci e Claudia voleva una vita avventurosa come la sua.
Pensava che avrebbe fatto la fotografa di guerra. In quegli anni, in edicola, uscivano pubblicazioni bellissime sulla guerra in Vietnam. C’erano foto magnifiche, ipnotiche che la attiravano. Poi, qualche anno dopo, pensò che, forse, avrebbe potuto scrivere. Già da bambina, con un amico scriveva racconti. Pensavano di venderli, Claudia per acquistare una 500 a sua madre, lui per regalare una pelliccia alla sua. Al Liceo poi si innamorò della filosofia. O meglio, la filosofia la fece sentire un po’ speciale, per la prima volta.
Dopo il liceo si iscrisse a Filosofia, a Bologna, però, lo stesso anno partì per gli Stati Uniti, assieme ad alcune amiche. Claudia andò alla ricerca della California dei beatnik di Kerouac. Niente studio, poco lavoro, tanta musica, concerti, viaggi sulla California 1 e giornate passate a Big Sur. Quando tornò, nel ’90, sua madre ebbe un ictus, si ruppe un’anca e contrasse l’epatite C da una trasfusione.
Una lunga malattia e tanto amore. Quella ferita d’amore per la quale le nostre strade si sono incontrate.
• Come sei entrata in contatto con la realtà dell’hospice ?
Nel periodo della laurea in Filosofia, nel 2012, dopo un lungo intervallo di studio e lavoro in ambito cinematografico, mi era stato offerto un lavoro su commissione dall’hospice Casa Madonna dell’Uliveto. All’inizio fui restia, ero veramente molto sofferente per la morte di mia madre. Poi accettai e fu un’esperienza magnifica. Realizzando quel filmato pensai che avrei potuto girare in quell’hospice un vero film documentario. Dopo la morte di mia madre c’erano cose che avevo imparato e sensazioni belle che avevo provato, che avrei voluto condividere, soprattutto con coloro che non erano riusciti ad andare oltre il corpo malato di mia madre, per spiegare loro che quando non riescono più a vedere la persona, ma solo la malattia, stanno perdendo qualcosa di sé e del mondo. Fu così che nacque The Perfect Circle.
• È stato difficoltoso realizzarlo?
Fin da subito fu evidente che sarebbe stato difficile da produrre, infatti dovetti farlo da sola, perché nessuno decise di rischiare. Sviluppai il film nel contesto di vari Workshop internazionali, anche molto prestigiosi, cosa che mi permise di fare un film molto cinematografico ed attirare l’attenzione del circuito del documentario. Ho studiato molto per realizzare questo film. Ed è proprio portandolo in giro, nei cinema d’Italia, che ho deciso di tornare al mio grande amore: la filosofia. Essere invitata a presentare il film in cornici anche molto prestigiose, registrare la grande fiducia dei miei interlocutori mi ha spinta a cercare nella filosofia gli strumenti per strutturare un vero discorso sul fine-vita, per avere una visione più completa e unirmi alla battaglia per colmare i buchi legislativi, culturali e sociali che costringono ancora troppe persone a morire male. Ora sto anche pensando un nuovo film e vorrei occuparmi di come si costruisce il senso del vivere. Ma è presto per parlarne.
• Cosa ha significato per te la realizzazione del film “The perfect circle”?
Quando ho iniziato a pensare e scrivere questo film, credevo che sarebbe stato semplicemente un nuovo film. Avevo una strategia di distribuzione, effettivamente innovativa, dei festival a cui avrei voluto mandare l’opera, e poi sarei passata ad altro. La mia esperienza personale con mia madre, da un lato era la motivazione per questo film e dall’altro la garanzia che il mio coinvolgimento fosse autentico, aspetto non di poco conto quando si vuole vendere un film. Poi ho iniziato a girarlo ed è accaduto quello che accade di solito, che i protagonisti del film sono diventati parte della mia vita, che io mi sono davvero legata a loro, ho sofferto con loro e li ho cercati anche dopo le riprese. Ciò che non mi aspettavo, però, è stato il modo in cui il mondo che stavo esplorando, quello delle cure palliative, mi è entrato dentro e si è preso cura di me senza che io lo avessi chiesto.
• Mi hai raccontato, quando ci siamo conosciute, che durante la permanenza in hospice, hai di nuovo provato quello strano benessere che sentivi quando eri accanto a tua madre…
Sì, che sentivo nella sua fase più avanzata di malattia, quando ormai mi ero abituata alla sua vita temporanea. Dopo le riprese ci ritiravamo, io e il direttore della fotografia, nei nostri alloggi, in un eremo immerso nelle colline, coi nostri pensieri, circondati da un silenzio ricco di dettagli. Ci stupivamo di stare così bene. Tutto sommato stavamo dodici ore al giorno in hospice. Durante le pause, mi capitava spesso di interrogare le psicologhe e il personale sulle emozioni che avevo provato durante la mia esperienza.
Per esempio: “Ero cattiva io quando mi rifiutavo di accettare, oppure ero una specie di santa quando finalmente accettai”? Perché non ero stata una brava figlia dall’inizio?
Mai prima di allora avevo pensato che la mia rabbia e la voglia di fuggire fossero “naturali”. L’hospice mi stava aiutando a dare un senso a metà della mia vita, quella passata accanto a mia madre. Non era certo previsto… Poi iniziai a portare il film nei cinema.
• Cosa non avevi previsto?
Quello che non avevo previsto è che tutto questo avrebbe risvegliato la mia passione per la filosofia e che mi avrebbe riportata sui banchi universitari per una Specialistica in Filosofia pratica… ma sta succedendo anche questo. Col senno di poi, posso dire che pensavo che questo sarebbe stato solo l’ennesimo film, voluto e amato come tutti gli altri, invece mi sta cambiando profondamente, mi sta dando serenità, mi ha dato nuovi obiettivi e non ho idea di dove mi porterà, anche se ho come la sensazione che stia facendo emergere un certo senso “di casa” che per un po’ avevo smarrito, come nella metafora del compasso che dà il nome al film.
• L’immagine del compasso che hai scelto è profonda. Ti va di parlarcene?
L’immagine del cerchio perfetto viene da una poesia di John Donne che racconta l’unione delle persone che si amano con l’immagine del compasso. Unite in una sola anima, in una sola sommità, le due gambe continueranno a disegnare cerchi perfetti, se una delle due sarà salda a terra, così che l’altra possa sempre ritornare dove tutto è iniziato. Me ne innamorai a 16 anni, al Liceo, e mi fu di grande conforto negli anni della malattia di mia madre. Mi aiutò a prepararmi al lutto, al distacco. Riempiva di presenza l’assenza a cui sarei andata incontro.
• Il sottotitolo del film invece?
Il sottotitolo coincide con il titolo di una poesia di Dylan Thomas. Una volta, mentre stavo presentando il film a possibili compratori e distributori, uno di loro, Stefan – un distributore tedesco – mi parlò di suo fratello e mi recitò quella poesia, dicendomi che il fratello non aveva mai trovato pace. Decisi di farne il sottotitolo, perché racconta di una rabbia che è un passaggio che non va negato e che dobbiamo accettare come espressione dell’umano. Quella rabbia io l’ho conosciuta bene e forse anche mia madre, ma certamente la conosceva Ivano, uno dei protagonisti di “The perfect circle” Ho pensato che fosse autentico esprimere nei titoli la rabbia e l’accettazione, come poli dialettici della cura.
• Com’ è nata l’idea del film?
Di solito rispondo che questo film è nato da un’esperienza personale, dai 19 anni di cura prestata a mia madre, afflitta da una malattia cronica, contratta durante un’operazione chirurgica; dico che l’accettazione della sua malattia mi ha permesso di vedere nella cura anche tanta bellezza, oltre alla durezza, e persino scoprire delle opportunità, in particolare quella di pensare il senso dell’umano da un’altra prospettiva; e concludo dicendo che è stato pensando a chi non riusciva più a vedere mia madre dentro quel corpo malato, che mi sono detta che avrei dovuto fare un film sulla cura, proprio per mostrare cosa ci perdiamo quando non siamo più in grado di vedere le persone, ma solo le loro condizioni.
• E quando ti chiesero di realizzare un audiovisivo per aiutare l’hospice a ridurre la diffidenza della cittadinanza e a trasformare l’idea che “là si va a morire” in “là si riconquista la dignità del vivere”?
All’inizio rifiutai. Ero restia, come dicevo. Mia madre stava ormai molto male e l’idea di passare del tempo in un hospice, in quel momento, non mi sembrava sostenibile. Ma poi il montatore (un danese molto cinico) con cui stavo lavorando ad un film mi disse: “Sei pazza? Devi farlo! Ti servirà per fare ricerca per un film fortissimo. Lo voglio montare io”. Disprezzai il suo cinismo, ma vidi quella proposta sotto una luce diversa; cominciai a pensare che in quel luogo ci potesse essere materiale per un nuovo film. Avrei dovuto, comunque, entro breve, pensare a qualcosa da proporre a produttori e a finanziatori. È il mio lavoro. Realizzai quell’audiovisivo che mi avevano commissionato l’anno successivo alla morte di mia madre e, inaspettatamente, non fu affatto angoscioso, anzi mi permise di affrontare alcuni dei conflitti più dolorosi che mi afflissero negli anni della malattia di mia madre: il mio rifiuto della sua malattia, i sentimenti contrastanti che provavo e l’odio per le persone che non sapevano vedere oltre il corpo malato di mia madre.
Quando passavano a trovarci parlavano di lei come se non ci fosse, eppure lei era lì, elegante e col suo sorriso migliore, felice di ricevere visite. Questo mi feriva, allora, ma anche mi diceva che io avevo saputo vedere oltre quel corpo malato e probabilmente questo era il motivo per cui la mia esperienza di cura, negli anni, diventò un’esperienza anche bellissima, intensa e piena di ricordi felici, nonostante l’angoscia, la preoccupazione e la rabbia. La vicinanza al suo corpo malato, per cui nutrivo sentimenti contrastanti, ad un certo punto mi fu sostenibile e poi desiderabile.
• Più ci riflettevi e forse più ti rendevi conto che questo era un tema per un tuo possibile film…
Il tema, nella cinematografia classica di genere, in particolare americana, è quella cosa che esce nel terzo atto e che, una volta che l’hai imparata, ti aiuta a vivere meglio la tua vita. Mi piace molto “rubare” spunti drammaturgici dalla scrittura del film di genere per inserirli nel documentario di creazione.
In hospice avevo conosciuto un medico che sarebbe stato il protagonista perfetto, avevo un tema, quindi ero pronta per scrivere un film. C’erano alcuni bandi in scadenza (Film Commission E-R, Fondo media-UE, Cineteca di Bologna), così scrissi il trattamento del film e lo mandai ai bandi. È così che un film nasce, nel momento in cui si ha un exposé da condividere; prima di allora ci sono solo idee e le idee non sono un film.
Scrissi e riscrissi il trattamento per almeno due anni prima di iniziare a fare le riprese e girai l’Europa per presentare il progetto ai forum internazionali del settore. La televisione nazionale belga pre-acquistò il film per la programmazione del sabato sera, in prima serata. Ormai The Perfect Circle esisteva nel mondo.
• Eri consapevole di realizzare un film sulla morte come parte della vita?
Non credo di aver mai voluto fare un film sulla morte. Volevo realizzare un film che costringesse lo spettatore a vedere la persona oltre il corpo malato, a vedere la vita dove altri vedono un annuncio di morte e lo aiutasse a conciliarsi con l’idea della provvisorietà dell’esistenza, a cui anche io, mio malgrado, mi ero abituata. L’hospice era il luogo perfetto, per la gentilezza dei modi e per la centralità della relazione col paziente, e ci vedevo riflessa la mia esperienza, anche se da “bricoleuse” delle cure palliative (che ho conosciuto solamente durante la realizzazione dell’audiovisivo su commissione, mia madre è morta prima dell’approvazione della Legge 38 del 2010 sulle cure palliative). La struttura mi offriva i luoghi e i modi dei conflitti dei protagonisti, sia interiori che esteriori, senza i quali non mi sarebbe stato possibile fare il film. Ma quando fu il momento di girare, il medico si ritirò, era in burn out, e dovetti rimediare su due pazienti. Questa fu la fortuna del film.